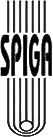di Romana Brina
Sembrava assurdo che il Coronavirus potesse colpire anche noi, non così forte! Gradualmente la parola pandemia si affacciava, nei resoconti di qualche cronista. Tuttavia, si stenta a credere alla realtà quando è scomoda. Eravamo increduli, ce lo doveva dire un’istanza autorevole. L’11 marzo 2020 l’OMS ha dato l’annuncio ufficiale. Come un timbro: adesso e a futura memoria.
La parola che temevamo, pandemia, vuol dire che la diffusione epidemica ci riguarda proprio tutti, nessuno escluso. Inaspettatamente l’umanità intera è resa consapevole della fragilità di ciascuno, del proprio essere indifesi di fronte a un virus con la corona, ironia della sorte!
La notizia arrivava in sordina, tra le luminarie delle feste e i pacchetti di Natale. L’esplosione dell’epidemia e il suo dilagare in Cina, ci aveva colti impauriti e sprovveduti, anche increduli.
Possibile che tanta furia potesse scatenarsi perfino nel nostro evoluto Occidente?
Ma no, possiamo stare tranquilli. Si tratta dell’ennesimo guaio che tocca a qualcun altro.
I cinesi, si sa, sono troppo distanti da noi, per cultura, lingua, abitudini e carattere sociale. Non sono loro gli Altri, quelli “che mangiano qualsiasi cosa che si muova… addirittura i topi?”.
Oplà, dal pipistrello all’uomo! A pensarci, chissà cos’avranno combinato per favorire il fantomatico salto di specie. Il pipistrello, in fondo, è un topo con le ali. Sembra fantascienza, ma è la realtà.
Una delle figure del test di Rorschach,che rammenta un pipistrello, è quella che evoca le fantasie raccapriccianti. Così l’origine oscura del Coronavirus, all’ombra di questa narrazione, assume tinte fosche e funeste, solleva nell’inconscio fantasmi perturbanti e angosce terrificanti. Da un angolo remoto dell’Estremo Oriente, salta fuori per l’umanità intera un’esperienza da brivido, tale da essere paragonata alla Spagnola, la tremenda epidemia che tra gli anni 1918 e 1920 provocò milioni di morti.
Ricordo ancora il tono turbato di mia nonna, quando bambina ascoltavo i suoi racconti sulla morte di suo padre a causa dell’epidemia. Non c’erano antibiotici allora.
Noi, grazie alla medicina moderna, ci siamo reputati forti e invincibili. Come ha detto Papa Francesco, durante le celebrazioni pasquali: “Ci credevamo sani in un mondo malato”.
Un mondo dove il tempo non basta mai. Si va sempre di fretta. Ci si sposta a velocità supersoniche. Ci si scambia tanto, anche senza saperlo. Eppure c’è stato chi, osservando meglio le cose del mondo, profeta inascoltato, lo aveva previsto.
Il resto è cronaca d’attualità. L’agenda setting è governata dalla notizia del secolo. Per giorni e giorni, settimane, mesi, non parleremo d’altro. Non penseremo ad altro. Il Covid-19 è in scena con tutti gli annessi e connessi: numeri, scetticismi, previsioni, ragionamenti, complottismi, commissioni, discussioni. Chi più ne ha più ne metta. Ciò che è più evidente, è l’incapacità ubiquitaria di gestire ciò che si credeva impossibile.
Tante le reazioni di sbigottimento, tendenzialmente tra due estremi: da una parte il terrore e l’angoscia di morte, dall’altra la noncuranza di chi sottovaluta le raccomandazioni e si ribella alle limitazioni della libertà personale. Sta di fatto che i momenti critici riescono a tirare fuori il meglio e il peggio della razza umana.
Infine, il lockdown! Il termine anglosassone aggiunge, forse, un sapore epico al fatto di restare chiusi in casa.
È uno scenario surreale, le strade delle città e i luoghi di aggregazione, i santuari della movida e dello shopping, sono deserti. Non c’è più niente da comprare, se non i generi di prima necessità, che vanno a ruba. Più niente da cercare. Nessuno da incontrare. Frenando improvvisamente la corsa quotidiana, ci si ritrova a vivere un tempo diverso, sospeso. Al di là delle esortazioni di medici e scienziati e delle motivazioni razionali che ci fanno intendere la necessità del rimanere isolati e distanti, cosa ne facciamo di questo tempo sospeso?
Talvolta la solitudine spaventa. Fermarsi vuol dire restare con se stessi, sentire, pensare…
Difficile immaginare gli effetti di tutto questo, come analisti siamo chiamati a pensare, a riflettere.
Una delle prime immagini che mi è venuta alla mente, nei primi giorni di quarantena, dal film C’è posta per te, è la scena dell’ascensore che si blocca, dove alcune persone rimangono ad aspettare che l’ascensore venga rimesso in moto. Ciascuno di loro, in quell’attesa, pensa di mettere in atto un cambiamento significativo per quando uscirà.
Ho sentito usare la parola setaccio, come metafora di questo tempo. Passare al vaglio il proprio esistere, le proprie scelte. Cosa troveremo nel nostro setaccio? Cose vecchie, come abitudini inutili o gusci vuoti. Oppure qualche pepita, che nella confusione e nella fretta, si era persa di vista?
Dare senso al nostro tempo. Questo, praticamente, siamo stati obbligati a fare. Nell’inerzia delle ore, a volte vuote come conchiglie che non risuonano di niente, si è fatto strada un pensiero nuovo, una scelta che aspettava, una persona dimenticata.
Come terapeuta, grazie alla tecnologia, ho sperimentato l’occasione di continuare a vedere alcuni dei miei pazienti. Èstata una sfida particolare e sorprendente. Mi sono confrontata con diversi colleghi e questo mi è stato di notevole aiuto. Sento di aver dovuto ritrovare il senso del mio setting interno. Ho compreso quanto la mia stanza, gli orari e le consuetudini fossero importanti, ma non imprescindibili. La montagna da scalare insieme, che Karen Horney indica quale metafora del percorso terapeutico, è un’immagine che assume ogni volta aspetti nuovi, se ci liberiamo dai preconcetti. In questo tempo, insieme ai pazienti che hanno accettato gli incontri virtuali, abbiamo esplorato nuove vie, camminamenti scomodi e precari, tra gli scorci delle loro case. Ho sperimentato che nell’imprevedibilità, quando per forza di cose allentiamo il controllo, si aprono finestre o panorami inaspettati. Ci colgono anche scrosci improvvisi di pioggia. Tutto questo fa parte del viaggio.
E poi ci sono quelli che non ce la fanno, che non riescono a sostenere neanche una telefonata. A loro penso in questo momento e mi preparo al ritorno nel luogo deputato. Sento che è venuto il momento.
Nonostante l’enorme complessità di tutto questo, la tristezza per le troppe morti, la malinconia degli incontri mancati, mi sento grata verso questo momento della nostra vita, come occasione per sentirmi viva con me stessa.
Siamo alla vigilia della cosiddetta fase 2. Come nel film stiamo per uscire dall’ascensore. Spero con tutte le mie forze che là fuori ci aspettino scelte di autenticità, per essere più vicini al nostro vero sé. Unico prodromo di un mondo migliore.